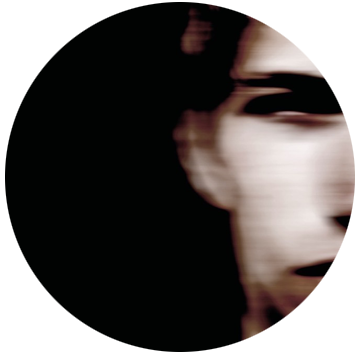
Delitto e castigo a Roma di Ettore Perrella
1. Dostoevskij notò che la realtà della cronaca a volte si dimostra artista, perché realizza delle trame così sorprendenti da superare di molto la capacità d’invenzione dei romanzieri (Diario di uno scrittore, Bompiani, Milano 2017, p. 121 e p. 604).
Una di queste situazioni si verificò nel 2016, a Roma, quando un ragazzo di ventitré anni, Luca Varani, fu ucciso e torturato in un appartamento da due un po’ meno giovani conoscenti, Manuel Fosso e Marco Prato. Questi avevano operato sotto effetto della cocaina, circostanza che, naturalmente, non basta di certo a spiegare – e ancora meno a giustificare – lo scatenarsi di tanta gratuita violenza.
Le similitudini fra questo episodio reale e la trama di Delitto e castigo sono immediatamente evidenti. Purtroppo, nella realtà della cronaca, a differenza che nel grande romanzo, sembra non essersi prodotta nessuna trasfigurazione morale dei colpevoli, anche se Manuel Fosso si autodenunciò subito ed è ancora in carcere, mentre Marco Prato, dopo aver tentato subito il suicidio, è riuscito a realizzarlo in prigione un anno dopo il delitto e poche ore prima della celebrazione del processo.
I giornali e i talk show hanno parlato per mesi di questo delitto, ma la vicenda aveva finito per essere dimenticata, prima che Nicola Lagioia la descrivesse in La città dei vivi (Einaudi, Torino 2020). Non escludo che la pubblicazione di questo libro sia l’unico tentativo che sia stato fatto fino ad oggi d’elaborare il lutto di questa dolorosa vicenda, con un racconto che è in primo luogo una riflessione sull’orrore.
Quando del massacro del giovane Luca Varani parlarono i media, tutti ci chiedemmo che cosa significasse questo episodio efferato e immotivato, ma nessuno riuscì a trovare una risposta convincente. Ricordo perfettamente che, in quei giorni, mi capitò di pensare che da questo episodio si sarebbe potuto trarre un romanzo, che, anche se forse non avrebbe potuto risolvere il problema dell’origine del male, avrebbe almeno consentito di riflettere su che paese è diventata l’Italia negli ultimi decenni. Perciò, quando ho saputo che Nicola Lagioia aveva pubblicato questo libro, ho voluto subito leggerlo. E per lo stesso motivo mi affretto ora a rendere accessibili ad altri le riflessioni che questa lettura mi ha costretto a fare.
Lagioia, pur avendo giù pubblicato dei romanzi (poco tempo fa ha vinto il premio Strega), in questo caso non fa il romanziere, perché non inventa nulla, ma si limita a riportare e a raccontare. Ciò nonostante il libro non è un reportage giornalistico, ma è un vero roman philosophique. Tuttavia qui le parti s’invertono: la cronaca brutale diventa, proprio perché non è inventata, una straordinaria invenzione letteraria, mentre l’invenzione di se stessi, che i tre protagonisti non hanno saputo, potuto, o forse voluto fare nella loro vita, è diventata un assassinio macabro come un sacrificio umano.
Come Dostoevskij, Lagioia dice, in un’intervista: “Alla fine, solo la realtà può permettersi il lusso di essere inverosimile. Documentando la realtà rendi veritiero ciò che la finzione non avrebbe reso credibile” (https://www.bonculture.it/culture/libri/la-citta-dei-vivi-roma-e-la-galassia-nera-di-chi-non-riesce-a-distogliersi-da-se-stesso-un-dialogo-con-nicola-lagioia).
In mezzo, fra la realtà irredimibile e la scrittura, c’è appunto l’autore, che non a caso, in alcuni punti cruciali del racconto, interviene in prima persona, parlando di se stesso (del resto non arbitrariamente, perché anche lui era stato subito incaricato da un periodico di seguire le indagini; il contenuto del libro viene per intero dalle interviste che egli aveva effettuato allora, oltre che dai documenti processuali).
“Abbiamo ucciso Umberto Eco”, urla un amico di Lagioia, ancora liceale, in un episodio che ci viene raccontato a metà del libro; e poco prima lo stesso amico aveva detto: “Ora ci vuole un sacrificio umano” (p. 274 sg.). Come si spiega, si chiede Lagioia, che quell’episodio, per loro, avesse prodotto solo uno scherzoso accoltellamento del Nome della rosa, mentre un sacrificio umano assurdamente letterale fu davvero realizzato da Manuel Foffo e Marco Prato? L’autore, beninteso, non trova una risposta a questa domanda, eppure è fondamentale per tutti noi che egli se la sia posta, perché chiunque potrebbe divenire, prima o poi, senza neppure sapere perché, una vittima o un carnefice.
Naturalmente, quando dico “chiunque”, mi riferisco anche a me stesso o ad una qualunque delle persone che mi vengono a trovare per fare un’analisi, e quindi per capire qualcosa di se stesse.
Su questo punto, c’è un ulteriore problema, nel racconto, perché Marco Prato ha frequentato per anni lo studio di un’analista (o psicoterapeuta?), il che non gli ha impedito prima di commettere questo atroce delitto e poi di suicidarsi; e non ha impedito alla sua terapeuta, pure interpellata più volte dalla difesa del suo ex cliente, di sottrarsi a queste richieste, come se l’assassinio da lui compiuto ed il suo suicidio non la riguardassero (p. 396). O invece la riguardavano troppo?
2. Confesso che alcune analogie fra la biografia di Lagioia (della quale se non so nulla, se non quello che egli scrive nel suo libro) e la mia vita addirittura m’inquietano. Entrambi siamo nati in Puglia ed entrambi ci siamo trasferiti altrove. E non mi pare un caso neppure che lui sia nato vent’anni dopo di me, mentre Luca Varani era di vent’anni più giovane di lui. Sono quasi precisamente tre generazioni. Che cosa è diventata l’Italia, fra il 1952, quando sono nato io, e il 2020, quando è uscito questo libro? Lagioia sa benissimo quali effetti ha prodotto, soprattutto sui più giovani, lo svuotamento culturale e civile prodotto dall’informatizzazione, nell’epoca di quello che chiama, senza falsi pudori, lo “sputtanamento globale” (p. 290).
Questi effetti sono evidentissimi nella vita dei tre protagonisti. Anche per questo credo che la lettura di questo libro possa dare un importante contributo ad una riflessione doverosa e comune. Non a caso, alla fine, il problema della responsabilità – anzi del libero arbitrio – viene chiaramente evocato dall’autore.
La responsabilità individuale, il libero arbitrio: in cosa ci saremmo trasformati, o dileguati, se ci fossimo liberati di questi due fondamentali pesi? Vivevamo in un mondo perennemente analizzato, scandagliato, setacciato da mille indagini e statistiche, ma al tempo stesso era un mondo inconoscibile, in cui era sempre più difficile capire chi fosse davvero responsabile di cosa. Crollava l’economia. Di chi era la colpa? […] Era paradossale che, nell’epoca in cui i principali cambiamenti sul pianeta erano imputabili alle nostre azioni, ricondurre un effetto alle cause che lo avevano generato, e soprattutto riuscire a farlo su un piano umano, individuale, fosse diventato l’esercizio più difficile di tutti (p. 409).
Da questo punto di vista Lagioia non ha dubbi: i due assassini sono responsabili della morte di Luca Varani, anche se, quando hanno commesso il delitto, non si sono neppure resi chiaramente conto d’essere proprio loro ad ucciderlo.
Addirittura sembravano non rendersene conto mentre lo facevano. “Ma allora sta accadendo davvero”, aveva pensato Manuel quando il massacro era iniziato […], come se ad agire non fossero stati loro ma qualcos’altro, un oscuro regista che aveva preso il sopravvento. […] Nessuno riusciva a imputarsi una colpa, nessuno riconosceva a se stesso la possibilità del male (p. 373).
È come dire che il fatto che Manuel e Marco non siano stati delle vittime meno di Luca non toglie che gli assassini sono stati proprio loro, mentre la vittima realmente sacrificata è divenuta il martire, vale a dire il testimone, d’una perdita di significato – d’un male, come giustamente dice Lagioia – che rende il mondo in cui viviamo sempre più colpevolmente insensato.
In effetti, nulla di ciò che ci viene raccontato in questo libro appare dotato d’un sia pur minimo spessore morale (se non l’amore che avevano per Luca i genitori e la sua ragazza). Le famiglie d’origine dei tre protagonisti erano fragili, pur essendo fondate su sentimenti autentici, che però non sono stati sufficienti a dare solidità alla vita dei tre giovani. Luca era stato adottato dai propri genitori nella ex Jugoslavia ed appariva a tutti – e sicuramente era – un ragazzo solare ed amabile, pur essendo dipendente dalle slot machines ed anche se, per arrotondare il suo magro stipendio, qualche volta spacciava e si prostituiva. Manuel, che apparteneva ad una famiglia benestante, non vi si sentiva integrato, ma aveva continuamente l’impressione d’esserne espulso. Infine Marco, pur avendo costruito con cura la sua immagine pubblica, continuava a desiderare di divenire donna e cercava come partner degli eterosessuali che come donna avrebbero dovuto considerarlo. Inoltre, come abbiamo detto, era depresso ed ha finito con il suicidarsi, poche ore prima del processo. Eppure, come abbiamo già detto, era stato seguito per anni da una terapeuta che egli stimava, ma che s’è rifiutata d’intervenire nel processo a supporto della sua difesa. E questo non manca di porre degli interrogativi molto radicali sulla funzione che dovrebbero avere, oggi, gli psicoterapeuti, oltre che sull’ideologia discutibile alla quale quasi sempre si riferiscono. La psicanalisi – ammesso che questa terapeuta fosse un’analista – dovrebbe avere una funzione simbolica – e di conseguenza anche sociale e politica –, in un momento in cui gli antichi contenuti valoriali sembrano essersi totalmente svuotati, senza venire sostituiti da altri. Quando questo non accade, la stessa terapia diventa complice dei ciechi meccanismi della patogenesi.
3. Naturalmente non possiamo ignorare il fatto che questo delitto è stato commesso in gran parte per caso, in una situazione in cui l’abuso di cocaina aveva per così dire fatto credere a Manuel e Marco che le proprie fantasie fossero la stessa cosa della realtà. È in un fantasma condiviso che un terzo veniva richiesto, al fine di rendere i due ugualmente complici d’una finzione di stupro. Luca fu chiamato per caso, dopo che due altri si erano sottratti alla celebrazione del rito. Luca, invece, parve subito il terzo ideale. Inoltre è inutile aggiungere che, se Manuel non avesse avuto, in un cassetto, dell’Alcover – un farmaco che può produrre rapidamente un coma etilico –, nulla sarebbe accaduto (p. 346 sg.). E non è affatto chiaro, nel racconto vertiginoso che di questo episodio troviamo nel libro di Lagioia, per quale motivo, quando il ragazzo è stato male per effetto del farmaco somministratogli in un cocktail, gli altri due siano passati quasi senza accorgersene dalla fantasia dello stupro alla realizzazione dell’assassinio. Il giovane Luca è stato quindi sacrificato senza motivo ad una divinità inesistente e crudele, senza che i due officianti avessero alcuna possibilità d’impedire la realizzazione di quell’orribile rito, pur non essendo in grado neppure di volerla. Certo, hanno voluto ucciderlo, tanto più che non ci sono affatto riusciti facilmente. Ma a volerlo erano loro o l’“oscuro regista” che li dominava da giorni? Quel “qualcos’altro”, in fondo, era pur sempre una parte di loro.
Senza dubbio nulla, in questo micidiale concatenarsi di coincidenze, attenua la loro colpa. Ma questa colpa – di nuovo – era solo loro? Sicuramente sì dal punto di vista giudiziario, ma sicuramente no dal punto di vista morale. Se Nicola Lagioia ha pubblicato questo libro, non è forse perché, come abbiamo già detto, anche lui si sentiva oscuramente coinvolto in questo episodio? E, se io adesso sto recensendo il suo libro, non è forse perché anch’io me ne sento in qualche modo responsabile? Ci sono delle colpe che trascendono i limiti dell’attribuzione individuale d’un delitto. Quando gli dei sono offesi, tutti siamo colpevoli. Perciò tutti gli italiani, quando di questo delitto parlarono le cronache, vi si sentirono implicati. E proprio questa è la situazione – la peste – dalla cui descrizione iniziano sia l’Edipo re, sia l’Iliade.
Se oggi le relazioni sociali si fondano più sull’immaginario che sul diritto, la religione o la morale, di chi è, in ultima istanza, la colpa della morte di Luca Varani, se non di tutti noi? E in primo luogo di coloro che, in quanto si occupano delle anime – come gli psicanalisti, o i preti, o gli insegnanti, o i poeti –, sono i primi responsabili dello svuotamento dei riferimenti sociali che dovrebbero, invece, costruire e difendere.
Proprio per questo che uno scrittore abbia raccontato questa vicenda, costruendo una storia inesorabile, in un libro orrendo e magnifico, mi pare un indizio del fatto che nulla è ancora perduto, se noi che abbiamo il dovere di occuparci del bene comune del senso dell’esistere non ci tiriamo indietro, ma continuiamo a svolgere umilmente e tenacemente il nostro compito.
Ci possiamo chiedere, in effetti, perché questo libro, in cui i vivi non vivono, ma scambiano la fantasia e l’angoscia con il desiderio e la vita, sia stato intitolato La città dei vivi. Non è un caso, in effetti, che questa vicenda si svolga a Roma, vale a dire in una città che, pur essendo morta più volte, continua ad esistere e ad essere la capitale, sia pure mitica, del mondo. Non a caso, proprio all’inizio del libro, troviamo, posta in esergo, una frase folgorante d’uno dei più fini e più cinici rappresentanti del potere politico italiano, Giulio Andreotti: “Non attribuiamo i guai di Roma agli eccessi di popolazione. Quando i romani erano solo due, uno uccise l’altro” (p. 3).
Nonostante questa vicenda orrenda, Roma continua ad essere viva. Nonostante le strade dissestate, l’accumulo della spazzatura e l’autocombustione degli autobus, questa città continua ad essere la città dei vivi, e non dei morti: anche se nessuno dei primi, fra le catacombe e le basiliche, può dimenticare i secondi.
Per questo non possiamo che essere grati a Nicola Lagioia – nomen omen, sia pure all’incontrario, in questo caso – d’aver deposto sulla tomba di questa giovane vittima dell’assurdo e della viltà un omaggio che senza dubbio lo farà tornare a vivere di nuovo, almeno per tutti coloro che leggeranno le pagine limpide, insieme misurate e dolenti, di questo suo libro.
